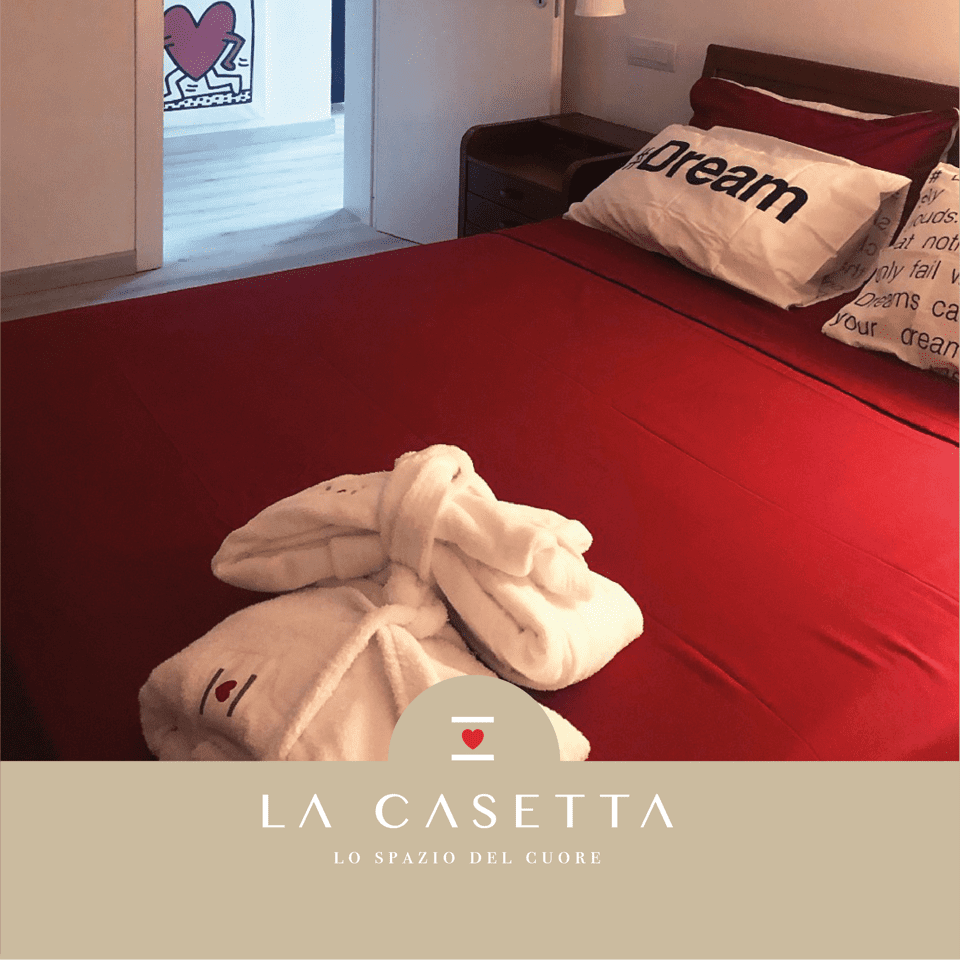Lo dico senza mezzi termini. Un paese dove per giocare una finale di Coppa Italia serve il benestare di un facinoroso che indossa una maglietta vergognosa è semplicemente un paese alla frutta. E’ la rovina più grande non solo per il nostro calcio, ma per il nostro Stato, inteso nell’accezione più istituzionale del termine. Una sconfitta senza attenuanti, un 6-0 tennistico degno del miglior Federer e inferto al peggior ultimo arrivato nel circuito ATP. Uno schiaffo al nostro sistema e alla nostra omertà. Keep calm, direbbero gli inglesi. Ma qua non c’è niente da stare calmi. Niente.
Andiamo con ordine.
Ieri sera (sabato 3 maggio, ndr) è andata in onda una della pagine più drammatiche della storia recente del nostro calcio (e di pagine drammatiche nella storia recente del nostro calcio non ce ne sono poche, basti pensare ai Raciti o al caso Sandri). In un clima totalmente onirico si discute tra capitani, arbitro, assistenti e dirigenti vari se giocare o meno, a seguito di quanto successo nel pomeriggio, cioè il colpo d’arma da fuoco che ha ferito un uomo, in prossimità dello stadio Olimpico di Roma. Si accerterà poi che l’episodio non ha nulla a che vedere con il calcio e che né l’uomo gravemente ferito né l’uomo da cui è partito il colpo fanno parte delle due fazioni delle tifoserie di Napoli o Fiorentina. Sono ormai le 21.35 quando capitani, arbitro e rappresentanti della Federazione e della Lega Calcio (sì, ho detto Federazione e Lega Calcio, mica pizze e fichi) si avvicinano alla recinzione che contiene gli ultras del Napoli, capeggiati da un signore a cui entro i primi 3 secondi che lo vedi capisci che non gli affideresti tua figlia manco per sbaglio se devi andare al lavoro.
Ecco, qui si ferma tutto. Qui muore il calcio, e insieme a esso, la società Italia. Qui muore il buon costume, qui muore la civiltà. Qui si spegne il lavoro di migliaia di persone che hanno lavorato, appunto, affinché ieri andasse diversamente. Qui muore la credibilità e l’onore di un paese. Qui moriamo noi. Questo potrebbe essere l’epitaffio della serata-funerale alla quale abbiamo assistito ieri. Quello che è successo ieri è solo uno dei tanti episodi – a cui, tra l’altro, basterà mettere un coperchio sopra e finiranno presto nel dimenticatoio – che distrugge, annienta la nostra onorabilità, ossia la parola a cui ci aggrappiamo per recuperare importanza nel mondo, quell’importanza che abbiamo perso per colpa di gente come questa.
La cosa veramente drammatica, però – e qui torno a fare il populista sessantottino, quindi da qui in poi sconsiglio la lettura ai moralisti facilmente impressionabili – è che il tessuto sociale, gli ambiti lavorativi, addirittura le strade pullulano di queste persone (che pare quindi siano a piede libero). In questo paese vinci solo se alzi la voce e ti ergi a capo (non eletto, mi ricorda qualcuno). Il trionfo della violenza. Un po’ come dire la vittoria della sconfitta. Un ossimoro. Eppure è così. E’ bastato fare un po’ di casino, lanciare qualche bomba carta (ferendo un vigile del fuoco) e subito il rappresentante della Lega ti si avvicina per chiederti gentilmente di stare calmo, e ti chiede pure se la partita può iniziare. Non lo so, ci devo pensare. Cosa dite, la facciamo giocare? Assurdo. Mi viene in mente Marco Giampaolo, che qualche mese fa, in seguito a una sconfitta del suo Brescia, si rifiutò di dare spiegazione alcuna ai suoi ultras e si ritirò privatamente, fintanto che qualcuno pensò fosse sparito. Invece no. Semplicemente (e giustamente) lui non volle assolutamente accettare di venire a discussione con delle persone che non gli rappresentavano niente, dal momento che con i suoi giocatori aveva già parlato, con i suoi dirigenti pure, e con il suo datore di lavoro l’avrebbe fatto di lì a poco. Per lui non c’era più nessuno da sentire. Ma, come detto prima, questo non è il primo caso (tutti ci ricordiamo similarmente del balordo serbo, Ivan Bogdanov, a Marassi), pure esulando dal pallone. In Italia funziona tutto così. Uno si fa largo a spinte, alza la voce, e decide per gli altri. C’è sempre un eroe che vidima documenti che non gli competono in qualche ufficio tecnico, c’è sempre qualche dirigente scolastico che decide la sospensione di un alunno senza radunare un consiglio docente, c’è sempre qualche medico obiettore che si prende libertà di scelta di cui nessuno lo ha titolato. E quindi, voi direte, eliminiamo questi elementi, questi violenti. E no, cari miei, perché qui le stesse colpe ce le ha chi subisce questo sopruso democratico. Le stesse colpe ce le hanno gli omertosi che permettono al violento di arrivare sopra il piedistallo a spinte. Le stesse colpe sono da spartire tra capo-ultrà e ultras. Non è più una questione di eliminare questi figuri indecorosi, il discorso è molto più ampio. Qui si deve cambiare testa e smetterla di far passare per piccolezza ogni minima cosa che favorisca loro e osteggi noi. Bisogna essere intransigenti, intolleranti, con questi qua. Bisogna finirla con il lascia passare e poi vederli lì, più in alto di noi, a decidere se una partita di calcio dev’essere giocata o meno. Se non poniamo davanti a noi questo granello di auto-critica entriamo automaticamente nello sbagliato. Noi siamo i buoni e loro i cattivi. No. Noi siamo i buoni, ma se non contrastiamo i cattivi lo diventiamo anche noi, cattivi.
Per la cronaca, Genny ‘a Carogna è figlio di Ciro De Tommaso, un affiliato al clan camorristico Rione Sanità dei Misso. E’ stato squalificato tramite il Daspo, ma ha scontato e può ora tornare a entrare in uno stadio. Porta una maglia imbarazzante, da provocare conati di vomito in una qualsiasi persona dotata di buon senso. Sulla sua maglietta c’è scritto ‘Speziale libero’. Quel ‘Speziale libero’ è Antonino Speziale, il tifoso catanese che nel febbraio 2007 uccise l’ispettore di Polizia Filippo Raciti, e che attualmente sta scontando otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, in seguito agli scontri che quello stesso giorno coinvolsero gli ultrà di Catania e Palermo in occasione del derby siciliano.
Come a dire, come cantava Gigliola Cinquetti: “E questa è casa mia, e qua comando io”.
Ma in fondo, che importa, da questo pomeriggio riprendono le partite, e l’italiota ammaestrato col campionato avrà già dimenticato tutto.
Riccardo Soro
© RIPRODUZIONE RISERVATA